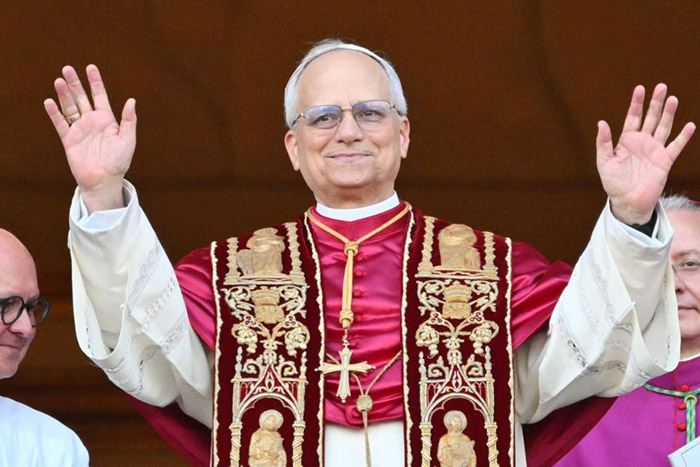numeri 90 - 98
Strutture di peccato che creano povertà e disuguaglianze estreme
90. A Medellín i Vescovi si pronunciarono a favore della scelta preferenziale per i poveri: «Il Cristo nostro salvatore non solo amò i poveri, bensì, “essendo ricco, si fece povero” visse nella povertà, incentrò la sua missione nell’annunciare la loro liberazione e fondò la sua Chiesa come segno di questa povertà fra gli uomini. [...] La povertà di tanti fratelli invoca giustizia, solidarietà, testimonianza, impegno, sforzo e superamento perché si compia pienamente la missione salvifica affidata da Cristo».[90] I Vescovi affermano
con forza che la Chiesa, per essere pienamente fedele alla sua vocazione, deve non solo condividere la condizione dei poveri, ma mettersi anche al loro fianco e impegnarsi fattivamente per la loro promozione integrale. La Conferenza di Puebla, di fronte a un aggravarsi della miseria in America Latina, confermò la decisione di Medellín con un’opzione franca e profetica in favore dei poveri e qualificò come “peccato sociale” le strutture di ingiustizia.
91. La carità è una forza che cambia la realtà, un’autentica potenza storica di cambiamento. Questa è la sorgente a cui deve attingere ogni impegno per «risolvere le cause strutturali della povertà»[91] e per avviarlo con urgenza. Auspico pertanto che «cresca il numero dei politici capaci di entrare in un autentico dialogo che si orienti efficacemente a sanare le radici profonde e non l’apparenza dei mali del mondo»,[92] perché «si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli più poveri della terra».[93]
92. È pertanto doveroso continuare a denunciare la “dittatura di un’economia che uccide” e riconoscere che «mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si collocano sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice. Tale squilibrio procede da ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Perciò negano il diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tutela del bene comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole».[94] Sebbene non manchino diverse teorie che tentano di giustificare lo stato attuale delle cose, o di spiegare che la razionalità economica esige da noi di aspettare che le forze invisibili del mercato risolvano tutto, la dignità di ogni persona umana dev’essere rispettata adesso, non domani, e la situazione di miseria di tante persone a cui viene negata questa dignità dev’essere un richiamo costante per la nostra coscienza.
93. Nell’Enciclica Dilexit nos Papa Francesco ha ricordato che il peccato sociale prende forma come “struttura di peccato” nella società, che «fa spesso parte di una mentalità dominante che considera normale o razionale quello che in realtà è solo egoismo e indifferenza. Tale fenomeno si può definire alienazione sociale».[95] Diventa normale ignorare i poveri e vivere come se non esistessero. Si presenta come la scelta ragionevole organizzare l’economia chiedendo sacrifici al popolo, per raggiungere certi scopi
che interessano ai potenti. Intanto per i poveri rimangono solo promesse di “gocce” che cadranno, finché una nuova crisi globale non li porterà di nuovo alla situazione precedente. È una vera e propria alienazione quella che porta a trovare solo scuse teoriche e non a cercare di risolvere oggi i problemi concreti di coloro che soffrono. Lo diceva già San Giovanni Paolo II: «È alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di consumo, rende più difficile la realizzazione di questo dono ed il costituirsi di questa solidarietà interumana».[96]
94. Dobbiamo impegnarci sempre di più a risolvere le cause strutturali della povertà. È un’urgenza che «non può attendere, non solo per un’esigenza pragmatica di ottenere risultati e di ordinare la società, ma per guarirla da una malattia che la rende fragile e indegna e che potrà solo portarla a nuove crisi. I piani assistenziali, che fanno fronte ad alcune urgenze, si dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie».[97] La mancanza di equità «è la radice dei mali sociali».[98] Infatti, «molte volte si constata che, di fatto, i diritti umani non sono uguali per tutti».[99]
95. Accade che «nel vigente modello “di successo” e “privatistico”, non sembra abbia senso investire affinché quelli che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano farsi strada nella vita».[100] La domanda che ritorna è sempre la stessa: i meno dotati non sono persone umane? I deboli non hanno la stessa nostra dignità? Quelli che sono nati con meno possibilità valgono meno come esseri umani, devono solo limitarsi a sopravvivere? Dalla risposta che diamo a queste domande dipende il valore delle nostre
società e da essa dipende pure il nostro futuro. O riconquistiamo la nostra dignità morale e spirituale o cadiamo come in un pozzo di sporcizia. Se non ci fermiamo a prendere le cose sul serio continueremo, in modi espliciti o dissimulati, a «legittimare l’attuale modello distributivo, in cui una minoranza si crede in diritto di consumare in una proporzione che sarebbe impossibile generalizzare, perché il pianeta non potrebbe nemmeno contenere i rifiuti di un simile consumo».[101]
96. Tra le questioni strutturali che non si può immaginare di risolvere dall’alto e che al più presto domandano di essere prese in carico c’è quella dei luoghi, degli spazi, delle case, delle città dove i poveri vivono e camminano. Lo sappiamo: «Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, sono piene di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!».[102] Allo stesso tempo «non possiamo tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale, dell’attuale modello di sviluppo e della cultura dello scarto sulla vita delle persone».[103] Infatti «il deterioramento dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta».[104]
97. Pertanto, è compito di tutti i membri del Popolo di Dio far sentire, pur in modi diversi, una voce che svegli, che denunci, che si esponga anche a costo di sembrare degli “stupidi”. Le strutture d’ingiustizia vanno riconosciute e distrutte con la forza del bene, attraverso il cambiamento delle mentalità ma anche, con l’aiuto delle scienze e della tecnica, attraverso lo sviluppo di politiche efficaci nella trasformazione della società. Va ricordato sempre che la proposta del Vangelo non è soltanto quella di un rapporto individuale e intimo col Signore. La proposta è più ampia: «È il Regno di Dio (cfr Lc 4,43); si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti. Dunque, tanto l’annuncio quanto l’esperienza cristiana tendono a provocare conseguenze sociali. Cerchiamo il suo Regno».[105]
98. Un documento, infine, che inizialmente non è stato ben accolto da tutti, ci offre una riflessione sempre attuale: «I difensori della “ortodossia” sono talvolta rimproverati di passività, di indulgenza o di complicità colpevoli nei confronti delle intollerabili situazioni di ingiustizia e dei regimi politici che mantengono tali situazioni. Si richiede da parte di tutti, e specialmente da parte dei pastori e dei responsabili, la conversione spirituale, l’intensità dell’amore di Dio e del prossimo, lo zelo per la giustizia e la pace, il senso evangelico dei poveri e della povertà. La preoccupazione della purezza della fede non deve essere disgiunta dalla preoccupazione di dare, mediante una vita teologale integrale, la risposta di un’efficace testimonianza di servizio del prossimo, e in modo tutto particolare del povero e dell’oppresso».[106]